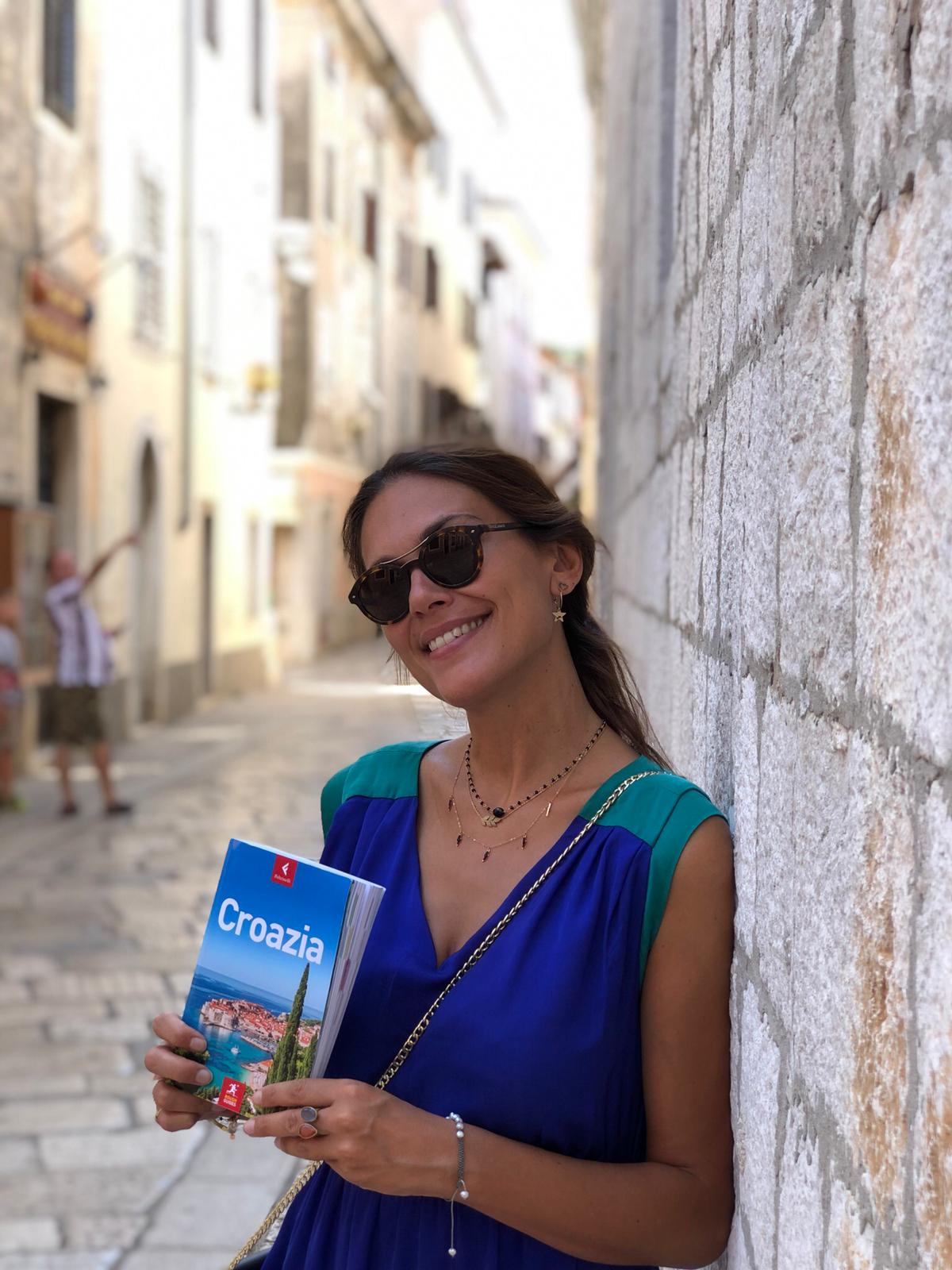In queste giornate strane sto cercando in qualche modo di recuperare un senso.
9 Marzo 2020
Aspettare
Sono le 16.30 del pomeriggio, la luce entra nel mio loft dalle finestre e guardo le piante del mio giardino. È l’inizio di Marzo, sta per tornare la primavera, tra poco sbocceranno le margherite. E l’oleandro e la passiflora.
Io sono al computer a scrivere, come tutti i giorni, anche se è tutto diverso.
Sento la forza del silenzio, in una città dove tutto sempre e costantemente si muove, nevrotico, ingordo e ossessivo. Sento il peso dell’assenza, delle automobili, di chi corre per entrare in ufficio, degli showroom che si preparano al prossimo evento, delle ragazze sul tram che chattano sui social network, dell’ansia del dover fare che disegna il cielo di Milano come i fili del tram.
Percepisco il senso dell’attesa che si propaga, come il virus, per la città.
Tutto è immobile e congelato.
Tutto all’improvviso è diventato paura.
Il fatto è che avevo da poco ricominciato a muovermi. Alzarmi dal divano, smettere di guardare il soffitto piangendo un amore (l’ennesimo) perduto.
Avevo lottato, ancora una volta, contro la mia innata tendenza al lamento e all’autolesionismo.
Mi ha lasciata anche lui.
Non servo a nulla.
Ho 35 anni, non ho un compagno, non ho figli, ho un lavoro precario e sto iniziando a perdere le idee. Non posso fare altro che arrendermi.
Ma poi non lo avevo fatto, non mi ero arresa. Avevo fatto un viaggio in quel tempo che in questo momento mi sembra così lontano da non permettermi altro che usare il passato- ed erano solo tre mesi fa. Avevo ritrovato dentro di me e nei libri e nei film ancora un barlume di senso per non farmi crollare. Per ridarmi la forza di ricominciare a muovermi, a proporre, a scrivere, a raccontare.
Non sono crollata allora, mi dico, e non crollerò neanche adesso. Anche se tutto intorno sembra essere cambiato in maniera inesorabile.
Il Virus è arrivato e ha spazzato via quello che c’era prima. Nessuno sa quanto durerà, a cosa porterà, che mondo ci sarà là fuori domani.
Siamo immersi in una bolla. Nelle pagine di un romanzo di fantascienza. In un film degli anni ’90 senza Bruce Willis che viene a salvarci.
Se sopravviveremo e la vita tornerà ad essere quella che conoscevamo prima, chissà quanti romanzi racconteranno questi giorni. Che racconteranno di come le città italiane si sono trasformate in un romanzo distopico.
Un mondo fatto di corrieri in biciletta che portano cibo e viveri a chi è costretto a rimanere in casa. Si lavora via skype, si seguono i concerti in diretta instagram dei cantanti famosi, ci si affoga nelle storie raccontate dalle serie tv. Non si può più godere di nulla. Delle strade, dei palazzi, dei monumenti, le chiese, i musei. Le mostre si guardano al computer con i tour virtuali. Il nostro cervello sa che le cose continuano ad esistere ma non possiamo più toccarle, vivere, sperimentarle.
Nel momento in cui scrivo ci sono ancora paesi che negano l’evidenza del problema. Che pensano che non toccherà a loro, perché le cose toccano sempre agli altri.
In questo momento negli ospedali di Milano i medici lottano per salvare le vite a più pazienti possibili. I casi aumentano giorno dopo giorno. Ogni giorno un pezzo delle nostre sicurezze viene eroso. Tutto quello che contava prima sembra non contare più niente.
I film che incasseranno più al cinema
Le idee per un romanzo che non riesco mai a portare a termine
La firma di un contratto di lavoro
Sentirmi ingrassata
In quale ristorante cenare
Le ambizioni
I desideri
I follower su instagram
Avere paura di diventare povera
Avere paura di rimanere sola
Le strade sono vuote, i bar e i ristoranti sono chiusi. Quel rumore di fondo che chiamavamo “vita” è cessato.
Esco, vado al supermercato di fronte a casa, ho finito la carta igienica, ho bisogno di comprarmi dei gelati. C’è il sole, fa caldo, ma la strada è deserta. C’è una coppia di ragazzi stranieri credo dall’est Europa. Ci guardiamo come marziani atterrati su un paese misterioso. Il paese che sta cercando di mettere pausa.
Non toccherà a me, toccherà agli altri, ci ripetiamo per sentirci al sicuro. Siamo giovani, stiamo bene, non è un nostro problema. Ma poi la situazione è precipitata. Non era vero che esistessero persone immuni, il Virus attacca tutti. Il Virus è un pericolo reale.
La paura ci si è attaccata addosso con la colla. Una paura mai provata da noi, generazioni che non hanno vissuto né fame né guerre che fino a due settimane fa viveva come unico rimpianto di aver scelto il paese sbagliato per andare in Erasmus.
Generazioni cresciute viaggiando, muovendosi, cambiando lavori e amori a un ritmo che non si era mai visto prima. Nuotando nelle liquidità dei rapporti, di lavoro e umani.
Abbiamo imparato a vivere così, correndo per raggiungere obiettivi da superare in velocità per poi sentirci nuovamente inadeguati.
“Scusa sto correndo, non posso fermarmi a guardarti”
Stressati, isterici, mai soddisfatti, eternamente collegati, costantemente troppo stanchi. Mai giustamente retribuiti, ma pazienza, l’importante è fare fatica.
Ci siamo ritrovati così: enormi palle egotiche incapaci ormai più di incontrarsi davvero.
“Ti lascio perché devo ritrovare me stesso e il me stesso non prevede più il noi”.
Prima che succedesse tutto questo, prima del Virus, prima che fosse necessario chiudersi in casa, avevo iniziato una mia personale ricerca verso una calma che non avevo mai trovato.
Non è stata una questione di consapevolezza né di coraggio, ma di necessità.
I casi della vita mi avevano portata a fermarmi, non perché lo volessi ma perché non riuscivo a fare altro.
Avevo abbracciato la mia fallibilità, i miei limiti e le mie fragilità. Avevo accettato che la vita non fosse altro che un continuo alternarsi di fasi, una ricerca di equilibrio continua tra attese e speranze, creazione di aspettative, perseguimento di obiettivi, illusioni e disillusioni. Avevo iniziato ad assaporare il benessere dello stare fermi per ritararsi. Come se avessimo un radar nella testa che ad un certo punto deve essere azzerato per ricominciare.
Però ho capito, ora mentre guardo il mio cactus immobile di fronte a me, che avevo sbagliato il punto di vista.
Avevo vissuto lo stare ferma come momento di ricarica. Una pausa isolata per poi riprendere la vita in mano agguantandola. Ricominciare a correre.
Adesso che tutto si è fermato intorno a me, capisco che bisogna andare oltre. Oltre le sessioni di mindfulness ritagliate tra un appuntamento e l’altro. Oltre le oasi di benessere che la società occidentale ci regala scimmiottando l’oriente e che viviamo come “rehab intellettuale ed emotivo”, una pausa da quella che comunque continuiamo a percepire come vita vera.
Bisogna imparare a riconsiderare il senso del tempo.
Liberarci, calmarci, ma non solo per riprendere il respiro.
“E’ strano- avevo detto alla mia psicanalista junghiana quando avevo deciso, due settimane dopo che Luca se n’era andato di casa, 5 mesi fa, di riprendere le sedute- non sento più la forza per fare niente. L’unica cosa che voglio è fermarmi”
“Lo accetti” mi aveva detto dietro agli occhiali rotondi, nello studio con la luce soffusa e il copridivano indiano.
“Non riesco più a reagire come ho sempre fatto, trovando alternative, continuando a muovermi”
Mi hanno insegnato a reagire sempre, su de doss diciamo noi al nord. Lo dice mia madre, lo dice mia nonna. Non c’è tempo per arrancare, non c’è tempo per bloccarsi. Domani è un altro giorno dice Rossella O’Hara.
Ma io ero bloccata e non potevo farci nulla.
Sprofondavo nel divano. Guardavo il soffitto. Perdevo il senso.
“Riparta da lei, cosa la identifica”
Non ho mai pensato a cosa mi identificasse. Una volta pensavo il mio lavoro. Ora no, non lo penso più. Ne ho cambiati così tanti da non sentire più una forma di definizione in quello che faccio.
Una volta ero la ragazza che parlava dei libri in tv.
Poi sono stata quella che faceva le interviste ai registi e agli attori di Hollywood.
Ma io, in tutto questo dov’ero?
“Forse sono le storie degli altri”
Le ho detto così, con la prima cosa che mi passava per la testa ma probabilmente quella più vera.
I libri, i film, le storie di personaggi reali e irreali. Era da lì che ero sempre partita e lì che sapevo che sarei tornata.
“Bene, ora è il momento che dalle storie degli altri inizi a vivere la sua”.
La sua sicurezza mi aveva rassicurata. Mi chiamo Marta, ho 35 anni, non ho mariti né figli, ho un lavoro precario, ma amo le storie degli altri e attraverso loro posso imparare a trovare la mia. Stando, per la prima volta nella mia vita, ferma.
“Niente è eterno. Ogni cosa è incompiuta e la chiave sta nell’imparare ad accettare la vita come si presenta , con l’imperfezione, l’incompiutezza e l’impermanenza”
Lo dice il principio del wabi sabi, pilastro dell’estetica e della filosofia giapponese che consiste nell’apprezzare la bellezza dell’imperfezione. Accettare che tutto si muove, niente è mai perfetto. “Cerchiamo il successo, la felicità, la perfezione. Paghiamo la ricerca con lo stress e il fallimento con la depressione. E intanto ci perdiamo tutto il resto”.
Siamo esseri umani, grosse palle organiche ripiene di errori, sentimenti negativi, fallimenti, paure. Ma sappiamo anche essere coraggiosi, intelligenti, sappiamo amare e fare del bene. Viviamo di cicli continui, saltellando dal passato al presente a volte non rendendocene nemmeno conto. A volte, la maggior parte, non riuscendo a staccarci dal primo per vivere davvero il secondo. Non sappiamo perdonare gli altri, ma soprattutto, non riusciamo a perdonare noi stessi.
Il wabi sabi mi ha conquistata subito dalla prima volta che ho visto per caso un libro con la copertina arancione che ha attirato il mio sguardo in libreria. Mi ha conquistata perché non predica soluzioni, ti insegna a porre attenzione al presente, di qualsiasi forma esso sia e ad accettarlo per quello che è. Abbracciando quello che succede, cercando di dargli una forma. Niente è davvero positivo come nulla è definitivamente negativo. La rabbia, l’ansia, la paura, sono i motori che ci portano a muoverci. Sono sentimenti negativi? Sì. Ma ci indirizzano, se non ci facciamo schiacciare, verso i nostri desideri più profondi. Nemmeno i desideri sono realmente positivi di per sé se diventano ossessioni e fonti di frustrazione. Anche i desideri, come le ambizioni, dobbiamo imparare a lasciarle andare se ci rendiamo conto che la nostra vita è cambiata, è andata avanti e quei desideri che avevamo un tempo, oggi, non hanno più valore.
Midge Maisel è la protagonista di The Marvelous Mrs Maisel, la serie tv che, insieme alla mia analista, mi ha riportata alla vita in quelle giornate in cui riuscivo solo a guardare il soffitto e pensare all’amore e al lavoro perduti. È una donna imperfetta che viene lasciata dal marito Joel che “deve ritrovare se stesso” nell’amore con una donna più semplice di sua moglie, la sua segretaria. Midge viene lasciata. Viene messa in una situazione di attesa a cui lei reagisce andandosi ad ubriacare in un bar, salendo su un palco e dando sfogo davanti ad un microfono delle sue sofferenze. Da quel punto, senza che lei lo capisca immediatamente, ma ci vorrà lo zampino dell’irresistibile Susie, la sua manager, i suoi desideri diventano altri. Non vuole più essere la moglie perfetta dell’upper west side che sta a casa a cucinare il tacchino e asseconda i sogni di gloria di un marito mediocre, ma vuole diventare una star della comicità.
Quando lui torna, una prima volta, lei dice “No”, perché “you left”, lui ha mollato, non solo lei, ma un progetto che avevano insieme. Quando sarà lei a voler tornare con lui, ma intanto la sua carriera è progredita, sarà lui a non volerla perché l’ha vista sul palco in tutta la sua scintillante comicità in dresscode perfetto. È brava. Più brava di lui.
Anche lui sarebbe voluto diventare una star della comicità, ma non ne ha le capacità. Lei sì. Lei può diventare una stella, non lui. È stata la rottura del matrimonio, la distruzione dei suoi schemi, il crollo di quella che lei pensava essere una vita perfetta che l’ha portata ad essere quella che veramente voleva essere.
Wabi sabi.
È il 9 Marzo 2020, il giorno in cui tutta l’Italia è stata messa in quarantena per prevenire gli effetti del Coronavirus. Non sappiamo cosa succederà, né quanto durerà questa situazione. Gli ospedali lombardi stanno vivendo un’emergenza sanitaria come mai prima. Le foto di donne e uomini in camice sostituiscono, sui social network, quelle degli influencer che pubblicizzano brand, eventi, luoghi dove svagarsi. Anche loro, gli influencer, che fino a ieri predicavano la filosofia del successo, portando le loro vite ad esempio di massima fonte di soddisfazione, raccontano le loro paure. Mostrano, in alcuni casi per la prima volta, le loro fragilità.
Io sono qui a casa, da sola. La solitudine, quella vera, ti batte nella testa come un tamburo quando pensi che non c’è nessuno, oltre alla tua famiglia d’origine a cui la tua vita importi davvero.
Uso molto instagram. Condivido consigli di lettura e visioni di film in queste giornate strane.
C’è paura, c’è ansia. C’è timore dell’ignoto. C’è voglia di buttarsi in un libro perché forse lì si troveranno risposte oltre che una fonte di distrazione.
“Fermarsi è un nuovo inizio”. Mi dice la mia psicoterapeuta via Skype, è la prima volta che ci incontriamo così.
“Ma per andare verso dove?”
Domando io
“Per capire dove andare bisogna dare valore al fermarsi per metterci in connessione con i nostri desideri”.
Fermarsi, bloccarsi, stare in silenzio. Capire i nostri desideri.
Penso che non mi meritavo che il mondo mi facesse ribloccare di nuovo. Penso che il karma mi si stia rivoltando ancora una volta contro, che non ne uscirò mai fuori. Mi autocommisero, mi do della poveretta.
Ma poi mi dico, wabi sabi.
“Fermarsi significa fare i conti con quello che resta” mi dice ancora nello schermo del telefono, con un’inquadratura che le mostra solo il naso e le ciocche di capelli biondi.
È una delle sue frasi preferite, me l’aveva già ripetuta altre volte.
Cosa resta. Resto io. Cosa mi manca. Tutto.
Mi mancano gli abbracci
Mi manca ridere con le mie amiche
Mi manca litigare con il mio fidanzato perché sono sempre io quella che deve sistemare la cucina
Mi manca passeggiare per strada guardando le case di Milano
Infilarmi la musica nelle orecchie per non pensare più
Attraversare il naviglio
Organizzare una cena con gli amici, quando nessuno ha voglia di uscire ma poi di colpo si fanno le due di notte e nessuno vuole tornare a casa
Sedermi a un tavolo di un bar
Guardare la gente che entra
Ascoltare le conversazioni degli altri
Entrare in libreria
Andare al cinema e abbandonarmi ad una storia
Sentire il calore umano addosso
Il sudore
Gli odori
Il caos del mondo
Mi manca tutto ma è forse creando il vuoto che si può capire quello che davvero ci serve. O almeno così mi sembra di aver letto da qualche parte.
Io di certo al momento sono vuota. Sola e vuota. Seduta sulla mia scrivania ricoperta di libri che vorrei rileggere.
Però resto. E sono io.
Provo a fare uno sforzo: accogliere il presente. E il mio presente è quello di una donna che si ferma in un mondo che si ferma. Che si rifugia nella tecnologia: i social network, lo smart working, le relazioni digitali che sono diventate loro, ora, l’unico nostro salvagente.
Proviamo a partire da qui. Dal valore dell’arresto. Dal peso del silenzio. Dagli equilibri che si formano nelle attese. E vediamo dove ci porta.